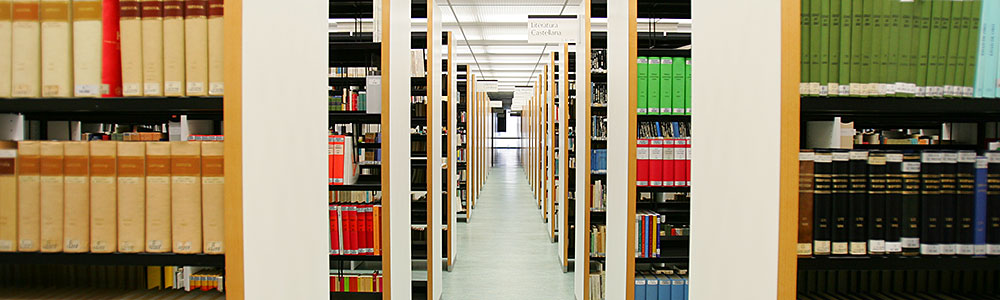Descripción del título
 "Comme t'ha fatto mammeta":...
"Comme t'ha fatto mammeta":...
This article surveys the literarytoposof thedescriptio puellaein Classical literature as a source for its later recreation in the classical Neapolitan song "Come facette mammeta" (1906). The subject knows two main modalities: one more erotic and the other more idealized. The analysis begins with a Greek epigram (AP 5.132) by the poet Philodemus of Gadara and with an elegy by Ovid (Am.1.5.17-26), which became the classical model in European letters. In Philodemus' and Ovid's treatments, the sensual description of the girl leads to the act of love. On another note, the description of the beloved, in an idealized manner which we call blazon, has precedents in Latin poetry (Catullus, Propertius) and was cultivated in the Renaissance from Petrarch on (Canzoniere 90). In the song "Come facette mammeta", the beloved is imagined having been created by her mother from certain ingredients. The description focuses on three physical attributes: the color of her body (a blend of white and red), the mouth (likened to strawberries and sweet spices), and the hair (compared to gold). This song, while generically evoking the libidinous descriptions of Philodemus and Ovid, and the idealized treatment by Petrarch, has been directly inspired by Propertius (2.3.9-28)
Questo articolo esamina il trattamento del topos letterario della descriptio puellae nella letteratura greco-latina, come fonte per la sua ricreazione nella canzone classica napoletana "Come facette mammeta" (1906). Il topos conosce due modalità principali: una più erotica e un'altra più idealizzata e platonica. Si parte dall'analisi di un epigramma greco (AP 5.132) del poeta Filodemo di Gàdara e di un'elegia di Ovidio (Am.1.5.17-26), che è diventata il modello per l'imitazione nella tradizione letteraria europea. Sia Filodemo che Ovidio coltivano il topos nella sua modalità erotica. Per altro verso, il tema della descrizione dell'amata, in una modalità idealizzata che chiamiamo blasone, ha precedenti nella poesia latina (Catullo, Properzio) ed è coltivato nel Rinascimento a partire da Petrarca (Canzoniere 90). Nella canzone "Come facette mammeta" viene rappresentata una descrizione sensuale della ragazza amata, immaginata come creata dalla madre da certi ingredienti. La descrizione si concentra su tre attributi fisici: la carnagione del suo corpo (una miscela di bianco e rosso), la bocca (assimilata a fragole e spezie dolci) e i capelli (paragonati all'oro). Questa canzone, sebbene richiami genericamente le descrizioni libidinose di Filodemo e Ovidio, si ispira a un passaggio di Properzio (2.3.9-28) e assimila anche motivi provenienti da Petrarca
Questo articolo esamina il trattamento del topos letterario della descriptio puellae nella letteratura greco-latina, come fonte per la sua ricreazione nella canzone classica napoletana "Come facette mammeta" (1906). Il topos conosce due modalità principali: una più erotica e un'altra più idealizzata e platonica. Si parte dall'analisi di un epigramma greco (AP 5.132) del poeta Filodemo di Gàdara e di un'elegia di Ovidio (Am.1.5.17-26), che è diventata il modello per l'imitazione nella tradizione letteraria europea. Sia Filodemo che Ovidio coltivano il topos nella sua modalità erotica. Per altro verso, il tema della descrizione dell'amata, in una modalità idealizzata che chiamiamo blasone, ha precedenti nella poesia latina (Catullo, Properzio) ed è coltivato nel Rinascimento a partire da Petrarca (Canzoniere 90). Nella canzone "Come facette mammeta" viene rappresentata una descrizione sensuale della ragazza amata, immaginata come creata dalla madre da certi ingredienti. La descrizione si concentra su tre attributi fisici: la carnagione del suo corpo (una miscela di bianco e rosso), la bocca (assimilata a fragole e spezie dolci) e i capelli (paragonati all'oro). Questa canzone, sebbene richiami genericamente le descrizioni libidinose di Filodemo e Ovidio, si ispira a un passaggio di Properzio (2.3.9-28) e assimila anche motivi provenienti da Petrarca
Analítica
analitica Rebiun36091868 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun36091868 240921s2024 xx o 000 0 ita d https://revistas.ucm.es/index.php/CFCL/article/view/97025 S9M oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/97025 https://revistas.ucm.es/index.php/index/oai CFCL DGCNT S9M S9M dc "Comme t'ha fatto mammeta": The Classical Literary Topos of the descriptio puellae in a Neapolitan Classical Song electronic resource].] "Comme t'ha fatto mammeta": Il topos classico della descriptio puellae in una canzone classica napoletana "Comme t'ha fatto mammeta": Il topos classico della descriptio puellae in una canzone classica napoletana Ediciones Complutense 2024-09-05 Ediciones Complutense application/pdf Open access content. Open access content star This article surveys the literarytoposof thedescriptio puellaein Classical literature as a source for its later recreation in the classical Neapolitan song "Come facette mammeta" (1906). The subject knows two main modalities: one more erotic and the other more idealized. The analysis begins with a Greek epigram (AP 5.132) by the poet Philodemus of Gadara and with an elegy by Ovid (Am.1.5.17-26), which became the classical model in European letters. In Philodemus' and Ovid's treatments, the sensual description of the girl leads to the act of love. On another note, the description of the beloved, in an idealized manner which we call blazon, has precedents in Latin poetry (Catullus, Propertius) and was cultivated in the Renaissance from Petrarch on (Canzoniere 90). In the song "Come facette mammeta", the beloved is imagined having been created by her mother from certain ingredients. The description focuses on three physical attributes: the color of her body (a blend of white and red), the mouth (likened to strawberries and sweet spices), and the hair (compared to gold). This song, while generically evoking the libidinous descriptions of Philodemus and Ovid, and the idealized treatment by Petrarch, has been directly inspired by Propertius (2.3.9-28) Questo articolo esamina il trattamento del topos letterario della descriptio puellae nella letteratura greco-latina, come fonte per la sua ricreazione nella canzone classica napoletana "Come facette mammeta" (1906). Il topos conosce due modalità principali: una più erotica e un'altra più idealizzata e platonica. Si parte dall'analisi di un epigramma greco (AP 5.132) del poeta Filodemo di Gàdara e di un'elegia di Ovidio (Am.1.5.17-26), che è diventata il modello per l'imitazione nella tradizione letteraria europea. Sia Filodemo che Ovidio coltivano il topos nella sua modalità erotica. Per altro verso, il tema della descrizione dell'amata, in una modalità idealizzata che chiamiamo blasone, ha precedenti nella poesia latina (Catullo, Properzio) ed è coltivato nel Rinascimento a partire da Petrarca (Canzoniere 90). Nella canzone "Come facette mammeta" viene rappresentata una descrizione sensuale della ragazza amata, immaginata come creata dalla madre da certi ingredienti. La descrizione si concentra su tre attributi fisici: la carnagione del suo corpo (una miscela di bianco e rosso), la bocca (assimilata a fragole e spezie dolci) e i capelli (paragonati all'oro). Questa canzone, sebbene richiami genericamente le descrizioni libidinose di Filodemo e Ovidio, si ispira a un passaggio di Properzio (2.3.9-28) e assimila anche motivi provenienti da Petrarca Questo articolo esamina il trattamento del topos letterario della descriptio puellae nella letteratura greco-latina, come fonte per la sua ricreazione nella canzone classica napoletana "Come facette mammeta" (1906). Il topos conosce due modalità principali: una più erotica e un'altra più idealizzata e platonica. Si parte dall'analisi di un epigramma greco (AP 5.132) del poeta Filodemo di Gàdara e di un'elegia di Ovidio (Am.1.5.17-26), che è diventata il modello per l'imitazione nella tradizione letteraria europea. Sia Filodemo che Ovidio coltivano il topos nella sua modalità erotica. Per altro verso, il tema della descrizione dell'amata, in una modalità idealizzata che chiamiamo blasone, ha precedenti nella poesia latina (Catullo, Properzio) ed è coltivato nel Rinascimento a partire da Petrarca (Canzoniere 90). Nella canzone "Come facette mammeta" viene rappresentata una descrizione sensuale della ragazza amata, immaginata come creata dalla madre da certi ingredienti. La descrizione si concentra su tre attributi fisici: la carnagione del suo corpo (una miscela di bianco e rosso), la bocca (assimilata a fragole e spezie dolci) e i capelli (paragonati all'oro). Questa canzone, sebbene richiami genericamente le descrizioni libidinose di Filodemo e Ovidio, si ispira a un passaggio di Properzio (2.3.9-28) e assimila anche motivi provenienti da Petrarca Derechos de autor 2024 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos Italian canzone napoletana descrizione dell'amata ricezione classica erotismo canzone napoletana descrizione dell'amata ricezione classica erotismo neapolitan song description of the beloved classical reception eroticism literary topos info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares Taccini, Lorenzo. cre Laguna Mariscal, Gabriel. cre Martínez Sariego, Mónica M. cre Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos; Vol. 44 No. 1 (2024); 93-103 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos; Vol. 44 No. 1 (2024); 93-103 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos; Vol. 44 No. 1 (2024); 93-103 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos; Vol. 44 Núm. 1 (2024); 93-103 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos; V. 44 N. 1 (2024); 93-103 1988-2343 1131-9062 https://revistas.ucm.es/index.php/CFCL/article/view/97025/4564456570348 /*ref*/Alvar, A. (2007), 'Descriptio puellae', Alvar, C. (ed.), Gran Enciclopedia Cervantina IV. Cueva de Montesionos - Entrelazamiento, Madrid, Castalia, 3362-3366. Barsby, J. (1973), Ovid. Amores I, Edited with Translation & Running Commentary by John Barsby, Oxford, Oxford University Press. Burke, P. (2000), El Renacimiento europeo. Centros y periferias, Barcelona, Crítica. Canali, L. (2000), Properzio. Elegie, Milano, Rizzoli. Courtney, E. (1990), 'Ovid and an epigram of Philodemus', Liverpool Classical Monthly 15.8, 117-118. Cropper, E. (1976), 'On Beautiful Women, Parmigianino, Petrarchismo, and the Vernacular Style', The Art Bulletin 58, 374-94. https://doi.org/10.1080/00043079.1976.10787307 Curtius, E. R. (1995), Letteratura europea e Medio Evo latino (traduzione di Anna Luzzatto), Firenze, La Nuova Italia Editrice Scandicci. Di Massa, S. (1961), Storia della canzone napoletana, Napoli, Fiorentino. Di Rocco E. e Boitani P. (eds.) (2015), Dall'antico al moderno. Immagini del classico nelle letterature europee, in Storia e Letteratura, raccolta di studi e testi, Roma, Fondazione Ettore Paratore -Edizioni di Storia e Letteratura. Dronke P. (1968), Medieval Latin and the Rise of European Love-Lyric: Volume I, Problems and interpretations, 2 ed., Oxford, Oxford University Press. Escobar Chico, Á. (2000), 'Hacia una definición lingüística del tópico literario', Myrtia 15, 123-160. Escobar Chico, Á. (2024), 'El locus a nomine y su funcionamiento en la literatura latina: de nuevo en torno al concepto de tópico', Cuadernos de Filología Latina. Estudios Latinos 43.2, 259-274. https://doi.org/10.5209/cfcl.92765 Garrison, D. H. (1978), Mild Frenzy. A Reading of Hellenistic Love Epigram (Hermes: Einelschriften-Heft 41), Wiesbaden, Hermes. Giangrande, G. (1968), 'Sympotic literature and epigram', L'épigramme grecque (Éntretiens sur l'Antiquité Classique. Tome XIV), Genève, Fondation Hardt, 93-117. Giangrande, G. (1974), 'Los tópicos helenísticos en la poesía latina', Eme